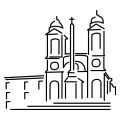I venerabili sposi Carlo Tancredi e Giulia, Marchesi di Barolo
François-Marie Léthel ocd
Papa Francesco ha riconosciuto le virtù eroiche dei due sposi Carlo Tancredi Falletti (1782-1838) e Giulia (Juliette) Colbert (1786-1864), Marchesi di Barolo. Li nomina anche nel suo importante discorso del 16 novembre 2023 ai partecipanti del convegno sulla dimensione comunitaria della santità, organizzato dal Dicastero per le Cause dei Santi, con una particolare insistenza sulla santità comune degli sposi.
La santità comune degli sposi come “moltiplicazione” della santità personale di ciascuno
Facendo riferimento alla sua Esortazione Apostolica C’est la confiance su santa Teresa di Lisieux, Papa Francesco ricorda come la santa contempla l’Amore di Gesù che abbraccia tutta l’umanità e ogni persona come se fosse unica nel mondo. La sua testimonianza è “frutto al tempo stesso della più alta esperienza mistica di amore personale e della «mistica del noi» (Cost. ap. Veritatis gaudium, 4a)”:
“In essa si compenetrano le due modalità di presenza del Signore, sia nell’intimo della singola persona (cfr Gv 14,23), sia in mezzo a quelli che sono riuniti nel suo Nome (cfr Mt 18,20); nel “castello dell’anima” e nel “castello della comunità”, per usare un’immagine cara a Teresa d’Avila (cfr Il castello interiore)”.
Secondo le parole del Papa, queste due modalità della presenza di Gesù “nell’intimo della persona” e “in mezzo a quelli che sono riuniti nel suo Nome” risplendono in modo eminente nella santità familiare. Qui vengono citati i nostri Marchesi di Barolo insieme ad altre coppie sante, nella luce della Santa Famiglia di Nazaret:
“Essa risplende eminentemente nella Santa Famiglia di Nazaret (cfr Gaudete et exsultate, 143). E tuttavia la Chiesa oggi ce ne propone molti altri esempi: «coppie di sposi sante, in cui ognuno dei coniugi è strumento per la santificazione dell’altro» (ibid. 141). Pensiamo ai santi Luigi e Zelia Martin; ai beati Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi; ai venerabili Tancredi e Giulia di Barolo; ai venerabili Sergio e Domenica Bernardini. La santità degli sposi, oltre che santità particolare di due persone distinte, è anche santità comune nella coniugalità: dunque moltiplicazione – e non semplice addizione – del dono personale di ciascuno, che si comunica“.
Questa affermazione della santità comune degli sposi come “moltiplicazione, e non semplice addizione del dono personale di ciascuno” è molto importante per Cause di beatificazione degli sposi. Bisogna considerare attentamente ciascuna delle due persone, perché può capitare che una sia santa, e non l’altra (per esempio santa Monica e il suo marito Patrizio). Se le due persone sono sante, bisogna allora mettere in luce la loro santità comune, questa “moltiplicazione”. Ma per questo, bisogna superare una concezione individualista della santità, ancora abbastanza diffusa[1].
Mi sembra importante considerare i due sposi insieme, con una Positio unica, come era stato fatto per i santi Luigi e Zelia Martin, per non separare quelli che Dio ha unito Invece, per i Barolo, ci sono state due Positiones separate, a distanza di 5 anni[2].
Le due Postiones dei Barolo sono eccellenti, ma una Positio unica sarebbe stata uno straordinario monumento, dal punto di vista teologico, storico e letterario, per evidenziare a partire dalla ricchissima documentazione la bellezza della loro santità comune. [3].
Il comune cammino di santità dei Marchesi di Barolo
Carlo Tancredi Falletti, marchese di Barolo, e Juliette Colbert di Maulévrier si sono incontrati a Parigi, alla corte di Napoleone, dove si sono sposati nel 1806. Lui aveva 24 anni e lei 20 anni. Questi due giovani aristocratici erano ricchissimi a tutti i livelli della grazia e della natura, condividendo la stessa profonda vita cristiana, lo stesso ideale di santità. Avevano in comune una grande cultura religiosa, scientifica, artistica e letteraria. Parlavano italiano, francese, inglese e tedesco. Hanno vissuto all’epoca del grande romanticismo europeo. Economicamente, erano anche molto ricchi.
Lo stesso Napoleone li stimava molto, a tal punto che ha voluto firmare il loro contratto di matrimonio insieme a sua moglie, l’imperatrice Giuseppina. Per lui, questo matrimonio tra due giovani appartenenti a grandi famiglie aristocratiche, una della Vandea, l’altra del Piemonte, aveva evidentemente un significato politico di alleanza.
Il loro matrimonio fu un vero matrimonio d’Amore, un amore perfettamente fedele e sempre più grande, durante i 32 anni di vita comune, fino alla morte di Tancredi nel 1838. Poi, Giulia è rimasta vedova per 26 anni fino alla sua morte nel 1864.
Questi sposi tanto ricchi erano allo stesso tempo colpiti dalla più grande povertà per una coppia: Non avevano figli[4]. Ma hanno vissuto questa povertà come una grazia di più grande vicinanza con i poveri, verso i quali hanno vissuto un’immensa paternità e maternità.
A partire dal 1814, dopo la caduta di Napoleone, la loro vita si svolge a Torino, nel loro splendido palazzo Barolo, vicino alla chiesa della Consolata. E’ una vita tutta di carità, secondo la loro condizione aristocratica, nello spirito di san Francesco di Sales. Non sono chiamati rinunciare alle loro ricchezze ma amministrarle il meglio possibile al servizio del prossimo e soprattutto dei più poveri e sofferenti.
E’ una carità coniugale, che riunisce due personalità molto diverse in una perfetta armonia, nella continua condivisone di tutti i loro progetti e di tutte le loro opere. E’ una carità sociale e politica, culturale e letteraria.
Il loro più grande amico è Silvio Pellico, che condivide la loro vita a partire dal 1834. Il suo capolavoro: Le mie prigioni, pubblicato nel 1832, aveva molto colpito Giulia che era impegnata da anni al servizio delle donne carcerate di Torino. Ci sono molti scritti del Pellico riguardo ai Marchesi di Barolo. E’ il testimone privilegiato della loro santità di coppia, della profondità del loro amore e in modo particolare della loro condivisione quotidiana[5]. Tra Giulia e Trancredi, c’è una perfetta unità nell’uguaglianza, senza la minima ombra di sospetto né di gelosia. C’è una totale fiducia reciproca.
Lo stesso Pellico ricorda una confidenza di Tancredi riguardo a Giulia: “Mi disse che sebbene dal principio della loro conoscenza egli l’avesse amata molto, ora ei l’amava più ancora”. Giulia nel suo testamento definisce il marito: “il migliore degli uomini” (T, p. 539-540).
Il loro reciproco amore diventa sempre più grande perché sono sempre a contatto con la fonte che è il Cuore di Gesù. I loro testi spirituali ci rivelano due cuori profondamente innamorati di Gesù. Così si esprime Tancredi:
“Gesù! Il promesso dell’Altissimo, il fedele, il paziente, tu ci hai rigenerato nel sangue e nel dolore della morte! Liberatore, Redentore, Salvatore nostro! Gesù, solo amico perfetto! Dio della mia vita! Amore degli amori, cuore divino e fonte inesauribile di clemenza, perdono, tenerezza generosa e costante, bontà senza limiti e senza esempio! Sì! Da oggi ritorno a te, né da te voglio più allontanarmi un solo momento, scostarmi con l’anima e col cuore dal pensiero tuo, dal tuo amore beato! Voglio d’ora innanzi riporre ogni mia gloria nell’appartenerti, nell’amarti, nel servirti, nel conformarmi in tutto alla tua divina volontà! Non sarebbe il più grande fra i delitti, se negassi il mio cuore ad un Dio che mi amò tanto da dare vita e sangue per salvarmi? Certo! La mia anima è il prezzo del sangue e della vita di Gesù. So quanto valga da quanto costò“[6].
Il loro impegno caritativo riguarda principalmente due forme estreme di povertà, quella delle donne carcerate per Giulia, e quella delle famiglie più povere per Tancredi.
Nelle sue Memorie, Giulia ci rivela la sua esperienza delle prigioni a partire dal 1814[7]. Come san Francesco si era avvicinato ai lebbrosi, così la giovane Marchesa entra nel carcere degli uomini, e ne descrive l’orrore. Poi, la visita al reparto delle donne la commuove ancora di più:
“Tanta loro abbiezione mi fece una pena, una vergogna, che non so rimembrare senza sentirla anche al presente. Dunque quelle infelici ed io eravamo membri d’una stessa famiglia, figlie dello stesso Padre, piante per lo stesso celeste giardino? Esse avevano avuto pure un’età d’innocenza! Erano chiamate pure all’eredità degli eletti! Come dunque… buon Dio!… Mi sovviene che strinsi le mani sul petto esclamando con queste parole“. (G, II, p. 14-15).
Immediatamente, nella luce della sua fede, la Marchesa si sente sorella di queste povere donne, e subito sente la chiamata a mettersi tutta al loro servizio. Superate le opposizioni iniziali della famiglia e del confessore, rimane poi lunghi momenti chiusa in carcere, cercando di toccare il cuore e di guadagnare la fiducia delle detenute, senza temere insulti e anche schiaffi e sputi. Ma spesso, anche con le più cattive, la carità vince, Non si sente mai superiore a queste donne più ferite, ma le vede sempre come sorelle e come amiche, lavorando alla loro piena riabilitazione in carcere e dopo la loro uscita. Alcune esprimono il desiderio di consacrarsi al Signore, e per loro fonda una nuova congregazione religiosa: Le sorelle penitenti di santa Maria Maddalena, che poi sarà approvata dal Papa.
Troviamo un bellissimo esempio della carità di Gulia verso le donne carcerate:
“Mi fu maestro il cuore: piansi, soffrii con loro. Mi provai talvolta di non fare la colazione prima d’andare in prigione, per sentirmi più appetitata, e così dimostrare più gusto nel dividere la zuppa colle detenute. Quelle volte s’accerchiavano intorno di me, guardavano stupite alla voglia con cui io mangiava il loro pan nero, e dicevano che esso sembrava loro migliore“[8].
Tancredi è stato sindaco di Torino e Consigliere di Stato, particolarmente attento alla “classe indigente” dei poveri operai e alla situazione drammatica dei loro bambini più piccoli. Per loro fonda le prime “sale d’asilo” nel palazzo Barolo, che era allo stesso tempo casa dei poveri e dei più grandi letterati italiani e europei. Il poeta francese Lamartine era il loro amico e ospite.
Il testo più espressivo della carità di Tancredi è il suo opuscolo sull’educazione della prima infanzia della classe indigente, pubblicato nel 1832[9]. Qui si rivela la sua profonda conoscenza della situazione drammatica delle famiglie povere, della sofferenza di questi bambini e delle loro mamme. Qui si rivela tutta la delicatezza del suo amore verso i bambini poveri, la sua grande stima per le famiglie povere, e specialmente per le donne.
Le riflessioni contenute in queste pagine corrispondono esattamente all’esperienza di Tancredi e di Giulia, alla profondità del loro amore paterno e materno verso questi numerosi bambini poveri accolti nella loro casa. E’ una carità illuminata dalla loro conoscenza delle buone iniziative in altri paesi, anche in ambiente non cattolico, in Inghilterra, Francia, Svizzera… Non si tratta di una carità privata, ma è proprio questa carità politica illuminata dal Vangelo, cioè dall’amore di Gesù verso i bambini. Così, la prima parte dell’opuscolo inizia con la parola di Gesù: Guardatevi dal disprezzare alcuno di questi piccoli (Mt 18, 10). Viene allora descritta la drammatica situazione di una famiglia povera di Torino, sicuramente una di quelle visitate ed aiutate da Tancredi e Giulia. La seconda parte, che riguarda la realizzazione concreta, inizia con un’altra parola di Gesù nel Vangelo: E chiunque accoglierà nel nome mio un fanciullo come questo accoglierà me stesso (Mt 18,5).
Dopo il fallimento delle trattative con il beato Antonio Rosmini (che non si è comportato bene in questa circostanza)[10], Tancredi avvia la fondazione di una nuova congregazione religiosa, le suore di sant’Anna, sempre con l’aiuto di Giulia. Così, questi laici sposati hanno fondato insieme due nuove congregazioni religiose.
Erano amici e benefattori dei santi sacerdoti torinesi: Cottolengo, Cafasso, Bosco e altri. Ma anche l’anticlericale Cavour è rimasto sempre il loro fedele amico, chiamando Tancredi “l’uomo più caritatevole del paese” (T, p. 462).
Durante l’epidemia di colera che colpì Torino nel 1835, Tancredi come Decurione della città, organizza ospedali, infermerie e “uffici di soccorso”, accogliendo anche nel suo palazzo alcune fanciulle rimaste orfane a causa del colera. Quando i ricchi e i nobili abbandonano Torino, Tancredi e Giulia si prodigano con grande generosità a favore degli ammalati, rischiando di morire per il bene degli altri. Da questo momento, la salute di Tancredi diventa più fragile.
Morte di Tancredi e vedovanza di Giulia
Colpito da una violenta febbre, ricevuti gli ultimi sacramenti, Tancredi muore tra le braccia di Giulia a Chiari (Brescia), in un miserabile albergo, il 4 settembre 1838, all’età di 56 anni, mentre faceva ritorno da un breve viaggio.
La morte dell’amato Sposo è per Giulia un immenso dolore, alla misura dell’immensità del loro amore, ma sempre trasfigurato dalla carità, dalla fede e dalla speranza. Qui, conviene citare la lettera scritta dal Pellico al fratello di Giulia, quattro giorni dopo la morte di Tancredi:
“Chi potrebbe dire ciò che ella ha sofferto e soffre? Ma Dio le ha dato e le dà una straordinaria forza d’animo. (…) Tutti pregano per lei (…) Tutti pregano anche per l’uomo eccellente che abbiamo perso, ma siamo persuasi che egli è in cielo. La Signora Marchesa ha tutte le ragioni di crederlo. Aveva una pietà da santo. Nella sua ultima confessione, la Signora Marchesa voleva allontanarsi, ma egli non lo volle, dicendo che non aveva segreto per sua moglie” (T, p. 474-475).
Questo particolare dell’ultima confessione di Tancredi è sicuramente la più bella testimonianza della sua totale comunione con Giulia e della trasparenza della sua anima.
Dopo la morte di Tancredi, Giulia stessa ha scritto una sublime lettera ad un nobile inglese, loro amico. E’ forse la più alta espressione del suo amore verso suo marito, un amore che continua dopo la morte e che si esprimerà in un nuovo dono di sé, ancora più radicale, al servizio dei poveri:
“Di recente, e voi lo sapete, la sventura mi ha percossa, mi ha travolta, mi ha trasformata. Io non sono più ormai che una naufraga nella vita, una sperduta, che sa di dover pagare un debito, sa di dover pareggiare una partita coi derelitti e i paria. La mia ricchezza è considerevole, ma la miseria che io vedo è tale che io non so misurare gli estremi… Dinanzi a me c’è una durissima strada; devo percorrerla senza stanchezza: è fiancheggiata da pezzenti, da miserabili, da rifiuti umani. Io devo vincere il ribrezzo e tutti i disgusti.
Sapete, milord, come ha chiuso la sua vita l’ultimo dei Marchesi Barolo? La morte l’ha sorpreso a tradimento lungo la faticosa via maestra: la via dei pezzenti! Egli ha agonizzato in una locanda miserabile: l’albergo dei poveri! (…).
Credetelo, milord, la vita ha talvolta degli ammonimenti atroci. Bambina, io ho sentito narrare le vicende paurose di quegli antenati miei di Francia, che hanno lasciato la testa sul patibolo.
Ieri ho veduto spezzarsi la mia ragione di vita, e in un’ora cupa di silenzio, dinanzi al mistero augusto della morte, nella tragica veglia funebre, che mi consentiva per l’ultima volta la contemplazione di un volto indicibilmente caro, io ho sofferto con lucidità spaventosa ed ho sentito l’anima mia trasformarsi.
In nome di colui, che è finito come un pezzente, io devo dedicarmi a tutti i miserabili. Io devo scontare i secolari privilegi degli avi, devo saldare i debiti che essi hanno contratto coi paria e con gli sfruttati; devo pareggiare l’implacabile conto, che ciascuno ha con la propria coscienza. Una voce cara e indulgente m’incita! Io non avrò più altra dolcezza che obbedire a quel comandamento” (G, II, p. 711).
Erede universale di Tancredi, Giulia è ricchissima, ma allo stesso tempo è la donna più povera, proprio come la vedova del Vangelo. Vedova senza figli, ha perso tutto con la morte dello Sposo tanto amato, ella ha perso tutto il tesoro della sua vita, ma questa estrema povertà la renderà ancora più vicina ai poveri, con una maternità più ampia. E’ bellissimo il suo modo di vedere nella morte di Tancredi la stessa morte dei poveri!
Giulia vive la sua vedovanza in continua comunione con lui in Cielo, con un nuovo impegno nella vita interiore, nella semplicità e nell’austerità, e nella carità verso i poveri. Qui, bisogna citare il testamento di Giulia scritto nel 1856, 18 anni dopo la morte del marito:
“La Provvidenza avendo voluto, nella sua sapienza, contro ogni probabilità apparente, e malgrado i voti del mio cuore, farmi sopravvivere al mio diletto marito, ed avendomi poi tolto il Padre, io dispongo della fortuna che mi è stata lasciata da coloro che io amava e la cui perdita mi è stata così dolorosa. Conosco perfettamente le pie intenzioni del mio defunto marito, il quale me le ha tante volte comunicate, relativamente all’impiego dei suoi beni. Mi ricordo il rinnovamento che me ne fece colle sue disposizioni nell’ultimo suo testamento, e specialmente nominandomi sua erede universale […], come in vita ho eseguito, e coll’aiuto di Dio eseguirò fedelmente i manifestatemi desideri, così qui mi accingo a farli eseguire dopo morte […]. Secondando pertanto i voti del mio amato marito, intendo di esercitare un atto di piena disponibilità e di assoluta padronanza, non essendo che nel foro interiore che io obbedisco e miro a compiere un dovere morale. Perciò dimandando i lumi dello Spirito Santo per fare in ogni cosa la volontà di Dio e la volontà di colui che, ora in cielo, mi otterrà, ne ho fiducia, la grazia di finir di fondare e stabilire le cose in questo mondo, in guisa da riempire le sante intensioni che egli aveva durante la sua vita, e che faranno ora la sua felicità eterna” (T. p. 298).
E’ bello vedere come l’amore di Giulia verso Tancredi non si è spento e non è anche diminuito con i lunghi anni della vedovanza. Anzi è sempre più vivo e fresco, avendo il Cielo come orizzonte. Nello stesso testamento, Giulia costituisce la nuova istituzione di carità che dovrà continuare dopo la sua morte, “l’Opera Barolo”, con la significativa espressione: “L’anima mia, in un con quella dell’amato mio Consorte” (T. p. 298).
Roma, 17 ottobre 2025
[1] Secondo le parole di Papa Francesco, si tratta di “un’idea pelagiana della santità, individualista ed elitaria” (C’estt la confiance, n. 17).
[2] Per i venerabili sposi Bernardini, c’erano anche due Positiones. Sono convinto che sarebbe meglio ritornare ad una Positio unica, con la richiesta, non di due voti separati, ma di un triplice voto, sulla santità personale di ciascuno, e se il voto è affermativo per tutti e due, sulla santità comune della coppia. Potrebbe capitare infatti che il voto sia negativo per tutti e due, o affermativo per uno e negativo per l’altro. Nella Positio unica, bisognerebbe distinguere tre parti: 1. la vita di ciascuno prima del matrimonio; 2. la loro vita comune; 3. la vita del vedovo o della vedova (che può essere un periodo lungo, come per la venerabile Marchesa di Barolo e per san Luigi Martin. La separazione delle Positiones crea dei problemi metodologici inutili. Per gli sposi Bernardini che hanno avuto 52 anni di vita comune, le principali testimonianze sono quelle dei loro 10 figli che non possono parlare separatamente del padre e della madre. Per le Positiones separate, si devono tagliare artificialmente queste testimonianze.
[3] Esiste un’abbondante documentazione scritta sui Marchesi di Barolo, riunita nelle due Positiones per la beatificazione. Attingerò a questa fonte, indicando la Positio di Giulia con la sigla G (con l’indicazione dei Volumi I e II) e quella di Tancredi con la sigla T. Tra i molti libri pubblicati, si possono indicare al primo posto i loro scritti: Con gli occhi del cuore. Giulia Colbert, Marchesa di Barolo. Memorie sulle carceri, Appunti di viaggio, Racconti (Milano, 1995, ed San Paolo); Marchesa Giulia di Barolo: Viaggio per l’Italia. Lettere d’amicizia a Silvio Pellico (1833-1834) (Casale Monferrato, 1994, ed Piemme); Carlo Tancredi Falletti Marchese di Barolo: Chiamati alla felicità. Scritti spirituali e pedagogici (Milano, 2002, ed San Paolo); Cristina Siccardi: Matrimonio, quel vincolo chiamato libertà. L’unione di fede speranza e carità di Tancredi Falletti di Barolo e Juliette Colbert (Torino, 2014, ed. Fontana di Siloe); Domenico Agasso Jr: Dentro la storia. Carlo Tancredi testimone di speranza (Milano, 2010, ed San Paolo); Giulia Colbert di Barolo Madre dei poveri (Libreria Editrice Vaticana, 2007. E’ l’eccellente Biografia Documenta della Positio, scritta da suor Ave Tago).
[4] Invece, i venerabili Sergio e Domenica Bernardini, poveri contadini, avranno la grande ricchezza di 10 figli.
[5] Così il Pellico ne parla in una lettera del 1839 al suo fratello Luigi, gesuita, un anno dopo la morte di Tancredi: “Mi piace l’uso che ho trovato in casa Barolo e, che ora continua tra la sig.a M.sa e me. I coniugi Barolo, non avendo prole, non avendo cura d’economia o di traffici, né altri di quegli affanni o pungenti desideri, sogliono rendere frequente l’esercizio della loquela; sarebbero diventati come tanti mariti e mogli, scarsi di quel vicendevole quotidiano cambio di piccole confidenze che tengono aperto un cuore coll’altro. Indi è che tanti sono annoiati, sono inamabili in famiglia e non si eccitano a brio se non ricevendo visite o facendone. I coniugi Barolo non per proponimento ma per felice disposizione non pensata avevano preso questo costume, che vidi fra loro, e conobbi eccellente. Dopo aver fatto ognuno, fino all’ora prossima al pranzo, la sua vita di lettura, di visite, di beneficenze, di seccature sofferte ecc. si trovavano insieme prima che, venissero i convitati od amici non intimi, e ciascuno diceva all’altro, così alla buona, tutta la storia della sua mezza giornata, confidenze di molta, di poca, o di nessuna grave entità, ma occasione sempre di mostrarsi il reciproco stato delle loro idee, pene e contentezze. Se poi uno era assente dall’altro, si scrivevano senza smorfie di sensibilaggine, ma partecipandosi cure, affari ed anche inezie per tenersi al corrente dei loro pensieri. Ho adottato, fin, da quando viveva l’ottimo Marchese, l’uso loro, e dopo averli uditi scambiarsi il loro breve rendiconto io soggiungeva: E io ho fatto ecc., ho veduto i tali ho approvato la tal cosa, ho giudicata cattiva la tal altra, mi sono dilettato del tal libro del tal progetto letterario, che eseguirò o manderò a spasso. Or così, seguo a fare colla sig.a Marchesa, e le nostre menti per tal modo hanno ogni giorno qualche pungolo d’innocente curiosità e manifestazione (T. p 297).
[6] Testo pubblicato nel volume: CARLO TANCREDI FALLETTI, MARCHESE DI BAROLO: Chiamati alla fellicità. Scritti spirituali e pedagogici (Milano, 2002, ed San Paolo, p. 45-46).
[7] Ecco il racconto della sua vocazione: “Ero sposa da qualche tempo a Torino, quando un giorno, nell’ottava di Pasqua, m’abbattei nell’accompagnamento del Viatico, che veniva portato dalla Parrocchia di Sant’Agostino agli ammalati, i quali non ponno andare in chiesa a far le divozioni. Io m’inginocchiai. Or mentre risonavan i devoti cantici, sentissi una voce rauca e scordata gridare: – Non il Viatico vorrei, ma la zuppa. – Quella bestemmia ed il tono di voce con cui era profferita, mi fecero trasalire. Alzai gli occhi al luogo donde era partita, e vidi le sbarre nere ed arrugginite delle carceri senatoriali. Tenevami dietro un vecchio e fidato servo: io gli dissi d’entrar meco in quella prigione. Desiderava dare a quell’infelice il poco denaro che portavo con me, temendo non la disperazione della fame avessegli strappata quella bestemmia, o sperando almeno che il denaro gioverebbe ad evitargli l’occasione di un altro sacrilegio simile a quello. Entrai nell’orribile carcere, e domandai d’essere condotta là, donde era venuto quel grido” (G. II, p. 13-14).
[8] G, II, p. 26. Questa bella espressione: “Mi fu maestro il cuore” risuona con un altro testo di Giulia, nel racconto dei suoi viaggi in Svizzera. Un padre di famiglia, davanti alla sofferenza della figlia abbandonata dal fidanzato, dice alla Marchesa: “Signora, voi avete il cuore ben fatto, e capirete senza dubbio l’afflizione di questa giovane mia figlia… Ditele una parola che la richiami all’antico coraggio” (G, II, p. 75)..
[9] Il testo è pubblicato nel volume Chiamati alla felicità, citato sopra (p. 75-116).
[10] Per sostituire le maestre laiche delle sale d’asilo nel loro palazzo, Giulia e Tancredi avevano pensato al nascente istituto delle Suore della Provvidenza, fondato dal Rosmini e già stabilite a Locarno. Tutta la difficoltà e finalmente l’impossibilità della collaborazione viene dal fatto che Rosmini rifiutava assolutamente che le sue suore facessero scuola ai bambini maschi (T. p. 423 e 434). “Il problema della presenza di maschi e femmine era diventato un serio ostacolo su cui il Rosmini non intendeva retrocedere” (p. 435). Infatti, egli stesso scriveva: “Io assolutamente disapprovo e proibisco che le Suore facciano scuola ai figli maschi” (p. 432). Il beato Antonio Rosmini è una delle più grandi figure del XIX secolo. E’ citato da Papa Francesco insieme al beato Cardinale Newman nella Veritatis Gaudium (n. 4). E’ un uomo straordinariamente aperto sul piano del pensiero filosofico e teologico. Invece, in questo contrasto con i Marchesi di Barolo, Rosmini si mostra molto chiuso e come “bloccato”, a differenza di tanti santi fondatori e fondatrici dell’epoca che non avevano paura di curare e aiutare uomini e donne, ragazzi e ragazze, bambini e bambine. I Marchesi, come laici sposati hanno un rapporto molto più semplice, sano e aperto a questo punto che riguarda la sessualità umana. Qui, è evidente che il Rosmini non riesce a uscire di un certo clericalismo, caratterizzato dalla paura della sessualità e da una certa ostilità verso i laici. Così non vuole neanche incontrare il Marchese (p 433) ed esprime al suo riguardo qualche giudizio negativo. Considerando serenamente questo limite del beato Rosmini, conviene ricordare le parole di Papa Francesco: “Non tutto quello che dice un santo è pienamente fedele al Vangelo, non tutto quello che fa è autentico e perfetto” (Gaudete et exsultate, n. 22). Invece, in tutta questa difficile vicenda, si vede la saggezza, l’apertura e la magnanimità di Tancredi, la sua capacità di perdonare tutto, e soprattutto la sue fede nella Provvidenza. E’ proprio l’impossibilità della collaborazione con Rosmini che lo conduce a fondare la nuova Congregazione delle suore di sant’Anna nel 1834. Questi contrasti tra i santi non possono rompere la comunione nella carità: “Alla fine, nonostante la questione assai complessa, e nonostante lo scambio di missive che palesavano idee opposte, il Rosmini seppe riconoscere umilmente sia signorilità d’animo che la magnanimità di Tancredi” (p. 437).